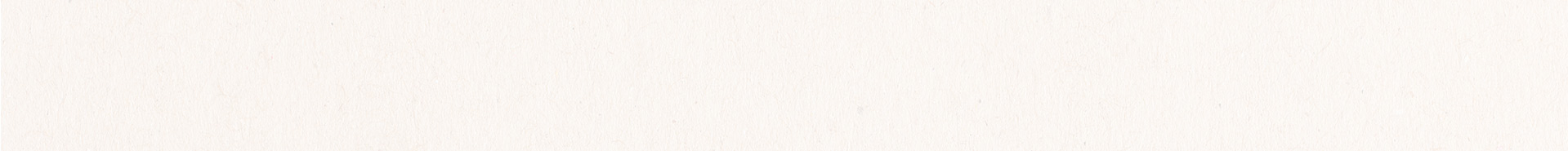La nuova frontiera che coniuga sostenibilità ambientale e redditività è il “carbon farming”, la cessione dei crediti di carbonio, che potrebbe spalancare un’opportunità alle imprese agricole e zootecniche (ma anche a quelle agro-forestali) per abbattere le emissioni di anidride carbonica. Un tema affrontato ieri alla 97ª Fazi di Montichiari, nel corso di un convegno che ha presentato i risultati intermedi del progetto europeo Life Carbon Farming (in corso fino al 2027), finanziato dall’Unione europea, che vede come coordinatore l’Institut de l’Elevage della Francia e coinvolge Spagna, Irlanda, Belgio, Germania e l’Italia con il Crea, il Crpa di Reggio Emilia, Unicarve, Aprocarne e l’Associazione italiana allevatori.
“Obiettivo del progetto – spiega Luciano Migliorati del Crea Zootecnia e Acquacoltura del centro di Lodi – è sviluppare un meccanismo di finanziamento del carbonio basato sui risultati ottenuti attraverso progetti di Carbon Farming, in grado di sostenere l’azione di 700 allevamenti da latte e da carne, che dovranno ridurre l’impronta di carbonio di almeno il 15% nell’arco di 5 anni”. Parallelamente, prosegue Migliorati, “lo scopo è promuovere il mercato dei crediti di carbonio per offrire agli agricoltori una fonte di reddito aggiuntiva e aiutare altri settori verso l’obiettivo della decarbonizzazione”.
Rispetto alla cessione dei crediti di carbonio nel sistema agro-forestale, partito in anticipo rispetto alla zootecnia e probabilmente più vicino alla partenza, il mercato legato al sequestro di CO2 dalle attività zootecniche potrebbero richiedere ancora due anni.
Operativamente, dice Migliorati, “si tratta di avviare pratiche che consentano di ridurre le emissioni di gas serra o di facilitare il sequestro del carbonio, per arrivare ad ottenere una certificazione delle riduzioni delle emissioni nell’ambito del progetto europeo, grazie a una metodologia comune di valutazione delle prestazioni ambientali ed un sistema di monitoraggio e di verifica”.
Sono 40 le pratiche di mitigazione incluse nel progetto “Carbon Farming”, che spaziano dalla gestione delle colture e dalla fertilizzazione alla gestione del bestiame e delle deiezioni animali, passando per soluzioni finalizzate al risparmio energetico (ad esempio eliminando l’aratura in campo o con sistemi per la produzione di energie rinnovabili), ma anche con azioni per il sequestro di carbonio in campo grazie a cover crops, agroforestazione, conversione di terreni coltivati a prato permanente (“puntiamo a ridurre nella razione alimentare delle bovine la soia, incrementando l’erba medica”, afferma Luca Cotti, consigliere di amministrazione del Consorzio del Parmigiano Reggiano). I crediti di carbonio, successivamente, vengono posti su una piattaforma di scambio dove far incontrare domanda e offerta. Difficile anticipare le cifre che potrebbero ottenere agricoltori e allevatori dalle attività di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ma i benefici economici potrebbero rendere dai 35 ai 70 euro per tonnellata di CO2 non emessa, per arrivare su un range che parte dai 100 euro per la cessione volontaria di crediti forestali di carbonio per arrivare nel giro di pochi anni a 200-220 euro.
La strada da compiere è ancora lunga. Tuttavia, sintetizza Saverio Maluccio del Crea Politica e Bioeconomia, “le aziende che acquistano crediti di carbonio riducono le emissioni due volte più velocemente di quelle che non li acquistano”. Per abbattere i costi di progettazione, che sono elevati, “le forme associative potrebbero giocare un ruolo chiave nell’aggregare i produttori e gestire i progetti di sequestro, ma siamo comunque di fronte a un’opportunità per ottenere un reddito aggiuntivo”.